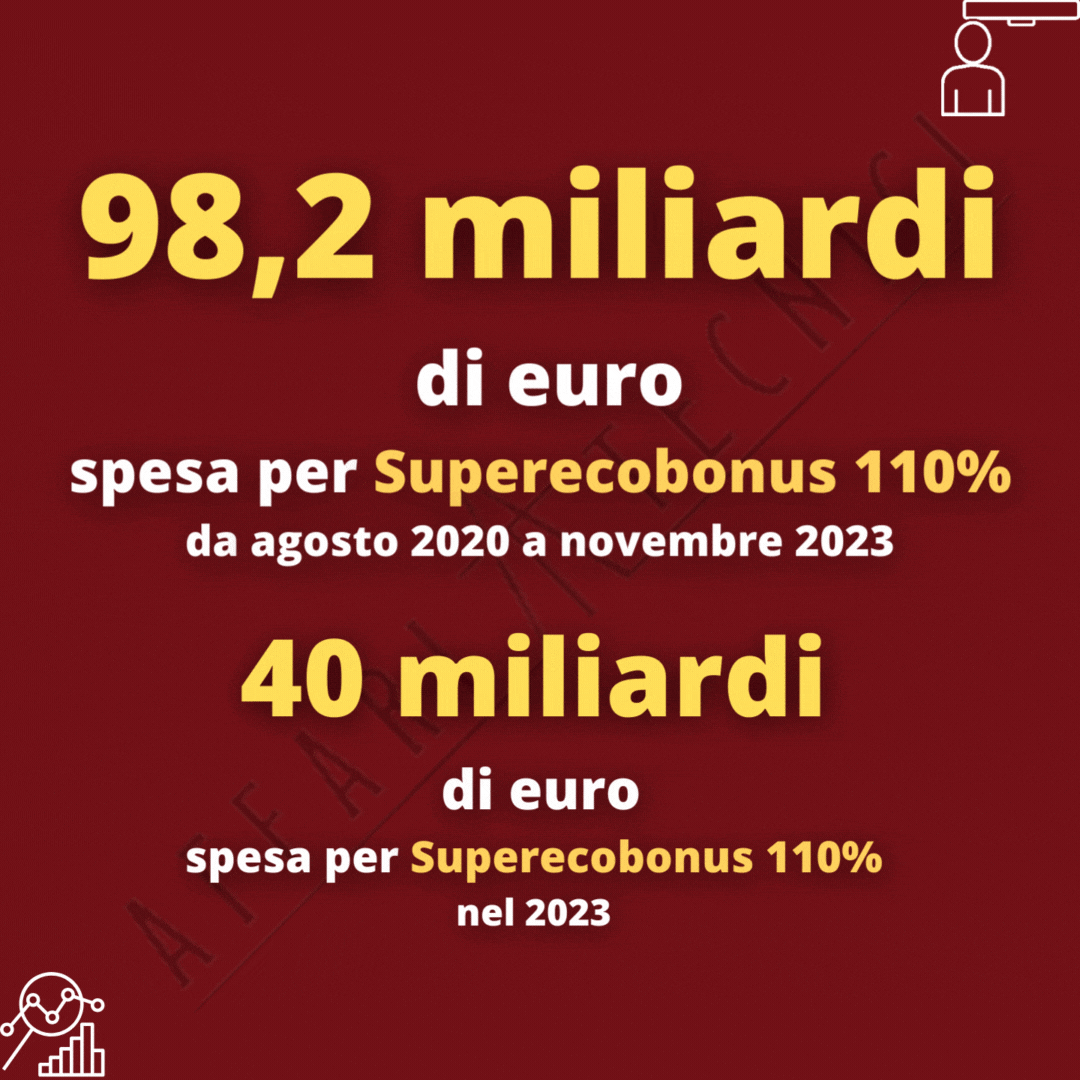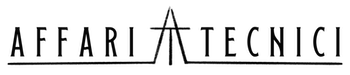Sabato 20 novembre, il Corriere della Sera ha dedicato il suo editoriale di apertura in prima pagina, a firma di Dario Di Vico, alla “crisi sottovalutata” del lavoro autonomo. Partendo dai “numeri” che rilevano negli ultimi mesi una diminuzione dei lavoratori autonomi in generale, si arriva a “scoprire” che “il 48% degli iscritti alle casse previdenziali degli Ordini professionali ha un reddito inferiore ai 20 mila euro annui”. La causa è presto individuata: “una quota consistente di colletti bianchi autonomi (cosa si fa per non utilizzare la parola “professionisti”) fa solo dei lavoretti”, “costretta a dar vita a una umiliante concorrenza al ribasso che finisce solo per distruggere valore e destrutturare il mercato”. Anche i responsabili sono scoperti: “la legislazione fiscale in materia di lavoro autonomo che si ostina a incentivare la piccola e piccolissima dimensione” ormai insufficiente ad affrontare la “complessità dell’economia contemporanea” ma soprattutto il “mondo politico” e “le associazioni e gli Ordini, preoccupati dall’invasione delle multinazionali” che hanno sempre voluto che “il terziario italiano restasse piccolo e indifeso e che non maturasse un’economia di servizi di stampo europeo”. La soluzione proposta è quella di un nuovo “paradigma”: “il lavoro autonomo competitivo e remunerativo in molti segmenti di mercato deve associarsi nelle forme e modalità più disparate, ma deve dotarsi di un’organizzazione seppur flessibile e ricominciare a generare valore”. Attenzione: non tutto il lavoro autonomo e professionale deve associarsi e organizzarsi ma solo quello già ora “competitivo e remunerativo”. Il paradigma deve cambiare ma non per tutti; c’è chi è destinato a rimanere nel limbo dei “lavoretti” e dei mini-redditi e chi invece, pur già ora “competitivo e remunerativo” deve fare un ulteriore salto in avanti e cominciare a generare “valore”.
Se intendiamo bene, il paradigma auspicato da Di Vico è quello di una nuova organizzazione del lavoro professionale, fatto di grandi strutture totalmente aperte all’apporto di capitali esterni, ritenuti necessari per affrontare i nuovi contesti di mercato. Ovviamente Dario Di Vico, un editorialista che da molti anni analizza e commenta le dinamiche del lavoro autonomo e professionale, sa perfettamente che dopo la fine del divieto di esercizio delle attività professionali in forma societaria, realizzato nel 2006 dalle cosiddette “lenzuolate” di Bersani, la materia è stata organicamente disciplinata dalla legge 183 del 12 novembre 2011 (articolo 10) e dal suo decreto attuativo DM 8 febbraio 2013 n. 34 che hanno introdotto le “società tra professionisti” (STP), consentendo l’ingresso in tali compagini, seppur con una quota di capitale sociale minoritaria, anche dei soci “non professionisti” ossia di puro capitale.
Come più volte sottolineato dal Consiglio Nazionale Ingegneri e dalla Rete Professioni Tecniche, la disciplina delle STP, almeno per il settore delle professioni tecniche, non è particolarmente incentivante. I dubbi sul regime fiscale applicabile ai redditi da esse prodotti (professionale o di capitale?) nonché alcuni vincoli posti dal legislatore ai professionisti (divieto di partecipare a più di una STP) hanno ridotto l’appeal di queste nuove strutture societarie. Le professioni tecniche dispongono già ora di un’alternativa che di fatto ingloba le caratteristiche di flessibilità e di totale apertura ai capitali esterni auspicati da Di Vico: le società di ingegneria.
Queste ultime, nate per operare esclusivamente nel settore degli appalti pubblici, sono state oggetto di una sanatoria (salvando i contratti illegittimamente sottoscritti con i privati a far data dall’11 agosto 1997) e legittimate ad operare liberamente anche nel mercato privato dalla legge 4 agosto 2017 n. 124 (la prima Legge per il mercato e la concorrenza del nostro Paese). Nelle società di ingegneria non c’è alcun limite alla partecipazione di soci “non professionisti” di puro capitale, che possono detenere anche il 100% delle quote societaria; unico vincolo è la presenza di un direttore tecnico, professionista iscritto all’albo, cui è demandata la responsabilità delle attività svolte. Non sembra però che l’estensione del modello delle “società di ingegneria” (e di altre forme di totale apertura al capitale esterno nelle attività professionali, come quello attuato dalla stessa Legge per la concorrenza 2017 nel settore delle farmacie private) possa davvero porre fine alla crisi del lavoro professionale nel nostro Paese.
L’apertura ai capitali esterni invocata da Di Vico, determinerebbe semplicemente un travaso di ricchezza dalle tasche dei professionisti (reddito professionale) a quello degli azionisti (valore). Per di più ai professionisti, che manterrebbero la piena responsabilità sulle prestazioni erogate, sarebbe riservato un trattamento economico in qualità di dipendenti non certo esaltante, mediamente inferiore del 20-30% rispetto ai livelli retributivi riconosciuto negli altri Paesi europei. Come dimostra il caso delle società di ingegneria (il cui numero è rimasto costante anche a seguito della liberalizzazione del 2017), esse risultano certamente più competitive delle strutture professionali tradizionali nel settore dei grandi appalti pubblici e privati, ma non idonee a rispondere alle richieste di una domanda frammentata e di piccola dimensione.
Anche nel settore delle gare pubbliche per servizi di ingegneria e architettura, come attesta il recente rapporto del Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri i liberi professionisti continuano ad aggiudicarsi oltre il 40% delle gare (oltre il 70% di quelle di importo fino a 75.000 euro). In realtà è la tipologia della committenza pubblica e privata nel nostro Paese, costituita da un tessuto di micro e piccole imprese e da decine di migliaia di stazioni appaltanti pubbliche, a rendere funzionale la frammentazione dei soggetti professionali. D’altro canto il livello di investimenti necessario per avviare un’attività professionale, seppur reso più elevato dalla complessità normativa cui viene sottoposta inopinatamente ogni attività autonoma nel nostro paese, resta dal punto della dotazione infrastrutturale e tecnologica sostanzialmente contenuto e abbordabile, e comunque non così sostenuto da necessitare il supporto di capitali esterni.
La verità è che ad incidere pesantemente sui redditi dei professionisti sono due fattori, che Di Vico nella sua analisi omette di considerare. Il primo è quello del numero di professionisti operanti nel nostro Paese. Nonostante gli strali della Commissione europea che continua a considerare un “ostacolo” alla concorrenza lo stesso esame di abilitazione previsto dalla nostra Costituzione per l’accesso alle professioni, l’Italia continua a detenere il più alto numero di professionisti in rapporto alla popolazione di ogni altro Paese europeo. Fino a quando questo numero non si ridurrà, la concorrenza tra i professionisti continuerà ad essere serrata.
A renderla anche “umiliante” è però un altro fattore, che discende anch’esso dalle “lenzuolate” del 2006, ed ovverossia l’abolizione delle tariffe professionali. Le tariffe, seppur blandamente applicate in passato dagli stessi professionisti nel settore privato, costituivano un argine di difesa verso i grandi committenti (banche, assicurazioni etc.) e nei confronti della pubblica amministrazione. Le stazioni appaltanti erano infatti costrette per legge a contenere i ribassi ammissibili nelle aggiudicazioni al “prezzo più basso” entro il ragionevole limite del 20% (nel settore degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura). Con la fine del regime tariffario i grandi committenti sono riusciti ad imporre ai professionisti convenzioni capestro mentre le stazioni appaltanti pubbliche hanno ripreso la tradizione delle “corvée” gratuite.
Sono i quindici anni di deregulation dei compensi professionali ad aver determinato quella “proletarizzazione” delle professioni liberali che il Corriere della Sera scopre ora ma che il Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri denuncia da oltre un decennio. Per porvi rimedio non è necessario un nuovo paradigma organizzativo affidato alla supervisione dei capitali esterni al mondo professionale ma l’attuazione del principio dell’equo compenso che tuteli i professionisti ed i loro redditi.